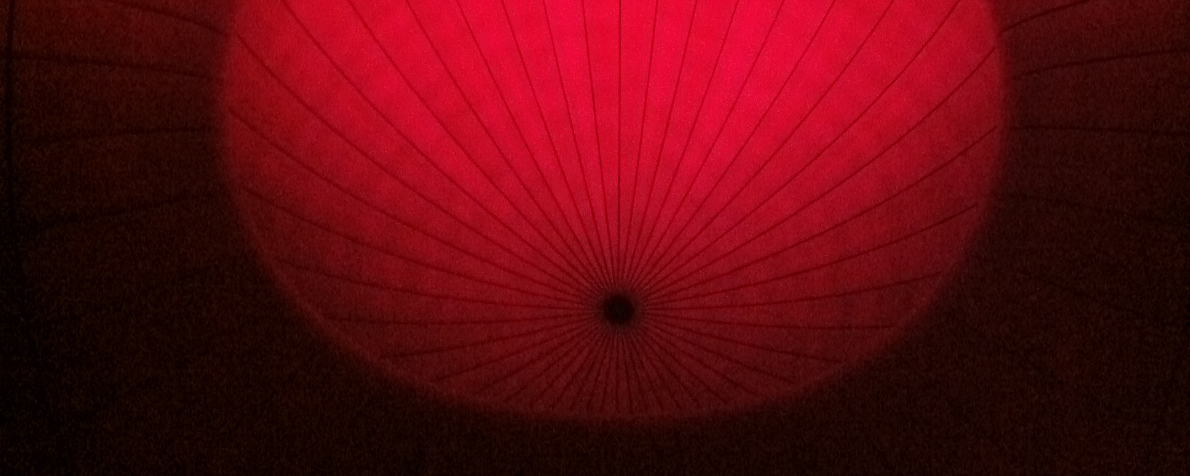
Recensione a: Asma Mhalla, Tecnopolitica. Come la tecnologia ci rende soldati, traduzione di Chiara Bongiovanni, add editore, Torino 2025, pp. 276, 22 euro (scheda libro)
Scritto da Ardita Osmani
7 minuti di lettura
Nel suo ultimo saggio, pubblicato da add editore nel marzo 2025, Asma Mhalla – politologa franco-algerina, ricercatrice affiliata al CNRS e all’EHESS, esperta di governance digitale e geopolitica delle tecnologie – propone un’analisi acuta e interdisciplinare delle trasformazioni dello Stato nell’era tecnologica. Tecnopolitica è un libro denso e ambizioso, che si muove tra teoria politica, studi strategici, economia digitale e filosofia del potere, con l’obiettivo di decifrare l’emergere di un nuovo paradigma: quello del “Big State”.
La tecnologia è ormai un attore centrale nel panorama politico, trasformando profondamente il modo in cui si costruisce consenso, si esercita il potere e si controlla l’informazione. Dai social network che diventano veri e propri campi di battaglia elettorale, all’uso strategico di piattaforme come WhatsApp e Telegram per la diffusione di messaggi e mobilitazioni, il digitale è uno spazio cruciale e controverso. La tecnologia non è solo uno strumento di comunicazione o di propaganda, ma un terreno cruciale di esercizio e trasformazione del potere politico, anche in Italia.
Negli ultimi anni, è emerso con forza il ruolo della tecnologia come vettore di controllo, sorveglianza e manipolazione. Un caso emblematico è quello del software Paragon, utilizzato per intercettare e spiare giornalisti, attivisti e figure politiche, svelando una dimensione inquietante della tecnopolitica italiana: il ricorso a strumenti di sorveglianza digitale per influenzare e reprimere il dissenso. Questa vicenda si inserisce in un più ampio contesto in cui la pandemia, la disinformazione e le campagne virali hanno reso ancora più urgente il tema della sovranità digitale e della trasparenza nell’uso delle tecnologie. Tra fake news e strategie di comunicazione politica, la politica si trova a confrontarsi con una sfida nuova e complessa, ovvero come garantire libertà e democrazia in un’epoca in cui il controllo delle informazioni può significare il controllo delle menti.
Il libro di Asma Mhalla inizia con una riflessione che prende avvio da una domanda molto classica, che cos’è lo Stato? Se la definizione canonica, ripresa nei manuali di scienza politica, lo descrive come “un’istituzione sovrana che esercita legittimamente il potere entro confini territoriali definiti”, Mhalla mostra come questa definizione sia oggi insufficiente a cogliere le configurazioni ibride e reticolari del potere statale contemporaneo.
Nel ripercorrere alcune tappe fondative del pensiero statuale, da Hobbes, con il suo Leviatano[1], a Max Weber[2] e alla sua celebre definizione dello Stato come monopolista legittimo della forza, l’autrice mette in luce la tensione tra ordine e violenza, tra potere visibile e infrastrutture invisibili. È su questo sfondo che prende forma la nozione di “Big State”, una nuova figura sovrana che, pur senza dissolvere lo Stato moderno, lo ibrida attraverso una simbiosi crescente con le grandi piattaforme tecnologiche, che «può essere allo stesso tempo politicamente ultra-autoritario ed economicamente iperliberale» (pp.22-23).
Il Big State è, nelle parole di Mhalla, «un Leviatano a due teste» una configurazione inedita in cui istituzioni pubbliche e attori privati, in particolare le Big Tech, cooperano, si sovrappongono e, talvolta, si confondono. Lungi dall’essere un semplice strumento regolativo, la tecnologia diventa così un dispositivo di potere in sé, capace di riconfigurare non solo le modalità di esercizio dell’autorità, ma la stessa antropologia politica della cittadinanza.
Se Weber e Hobbes rappresentano due pilastri del pensiero politico tradizionale, Mhalla integra al dibattito un’altra chiave interpretativa fondamentale, la visione marxista dello Stato come strumento di dominazione economica. Riprendendo Marx, l’autrice rifiuta l’idea dello Stato come entità neutrale o indipendente, descrivendolo piuttosto come una sovrastruttura ideologica al servizio della classe dominante, funzionale alla riproduzione delle condizioni materiali del capitalismo. Secondo Mhalla, è proprio attraverso lo Stato che si organizzano e si mantengono rapporti di produzione diseguali, garantendo la continuità del potere economico e sociale. In questo senso, lo Stato agisce come garante del capitale, legittimando la sua egemonia non solo mediante la forza, ma anche attraverso il consenso e l’ideologia. Questa prospettiva costituisce il punto di partenza per analizzare la transizione dallo State al Big State, che Mhalla interpreta non soltanto come un’evoluzione tecnologica, ma come un rafforzamento di forme più sottili e pervasive di controllo. Le infrastrutture digitali, in questa lettura, diventano strumenti centrali di gestione della produzione, della sorveglianza e della costruzione ideologica nel contesto del capitalismo 4.0.
Un altro elemento centrale della riflessione di Asma Mhalla è il ruolo dell’intelligenza artificiale, che l’autrice identifica come una delle infrastrutture decisive del nuovo ordine tecnopolitico. Riprendendo Marx, Mhalla definisce l’intelligenza artificiale come una “infrastruttura-sistema» (p. 97), collocata al cuore della dimostrazione «Metastruttura–Infrastruttura–Tecnologia Totale», di cui rappresenta, a suo dire, «l’immagine più convincente». In questa formulazione, l’intelligenza artificiale non è semplicemente uno strumento o una tecnologia tra le altre, ma è la forma stessa attraverso cui si esprime il nuovo rapporto tra potere politico, produzione e conoscenza. È, in altre parole, il dispositivo cardine di un capitalismo che ha interiorizzato la logica dell’automazione e della previsione, trasformando l’elaborazione dei dati in una funzione strategica di governo.
In filigrana si intravede, in questo passaggio, una chiara eredità foucaultiana. Come nel biopotere teorizzato da Michel Foucault[3], anche la tecnopolitica del Big State descritta da Mhalla non opera più attraverso l’imposizione diretta, bensì mediante un insieme di dispositivi di cattura che plasmano i comportamenti, modulano l’attenzione e condizionano l’immaginario collettivo. L’azione del potere si sposta così dal dominio visibile all’amministrazione degli spazi cognitivi e affettivi; il controllo non si esercita più sul corpo, ma sull’elaborazione dei desideri, delle percezioni e delle emozioni.
Da questo punto di vista anche la sovranità si riconfigura profondamente. Da verticale e centralizzata, diventa reticolare, diffusa e interconnessa, inscritta nelle infrastrutture stesse della vita digitale. Mhalla parla di controlli “soft”, forme di potere che non si impongono con la coercizione, ma che operano per adesione, consenso e abitudine. Si tratta di un potere tanto più efficace quanto meno percepito, che si insinua nei processi quotidiani di comunicazione, consumo e produzione di senso.
All’interno di questo quadro, l’autrice introduce anche il concetto di “tech diplomacy”, per descrivere l’emergere di un nuovo regime di governance globale in cui gli Stati «devono parlare non con entità superiori, ma complementari», aprendo la strada a una co-governance tra Big Tech e Big State (p. 70). Ciò che Mhalla mette in luce è la dissoluzione delle tradizionali gerarchie del potere politico, ovvero, le grandi piattaforme tecnologiche non si pongono in contrapposizione agli Stati, ma ne diventano alleati funzionali, co-amministratori di un sistema che integra infrastrutture digitali, potere economico e capacità normativa.
In questa prospettiva, la “Tecnologia Totale” non è soltanto una metafora, ma una condizione politica concreta, in cui la logica del calcolo, della profilazione e della previsione automatizzata si sostituisce progressivamente ai processi deliberativi e decisionali della politica tradizionale. L’intelligenza artificiale, come infrastruttura-sistema, non agisce solo nel dominio tecnico, ma diventa il principio organizzatore del nuovo potere sovrano, capace di unificare produzione, sorveglianza e ideologia in un unico continuum operativo.
La guerra cognitiva e l’infrastruttura mentale del potere
Una delle sezioni più incisive del volume è dedicata a ciò che Mhalla definisce la «guerra cognitiva», una nuova frontiera del conflitto, in cui l’obiettivo non è più tanto la conquista territoriale, quanto la colonizzazione dell’immaginario (pp.125-128). Il paradigma che viene citato dall’autrice è quello delineato da Sun Tzu[4]: «vincere senza combattere». La guerra, nel XXI secolo, si gioca sempre più sul piano mentale, dove la disinformazione, la manipolazione algoritmica e la saturazione dell’attenzione diventano armi strategiche.
Qui l’autrice richiama le ricerche di Daniel Kahneman[5], e in particolare la distinzione tra “Sistema 1” e “Sistema 2” del pensiero, il primo rapido, intuitivo, vulnerabile; il secondo riflessivo, ma lento e meno attivato nel contesto digitale. È il Sistema 1, osserva Mhalla, a essere bersaglio privilegiato delle operazioni psicologiche e di propaganda che caratterizzano la guerra dell’informazione contemporanea.
Ma il cuore del problema, non risiede soltanto nella diffusione di contenuti falsi, bensì in un attacco più profondo: la delegittimazione dei presupposti cognitivi su cui si fondano la coesione sociale e il giudizio democratico. La posta in gioco diventa così la possibilità stessa di un pensiero critico autonomo. In questo senso, la guerra cognitiva è una forma di potere totalizzante che agisce non sui corpi, ma sulle menti, non imponendo il silenzio, ma manipolando il rumore.
Su questo punto, il pensiero di Shoshana Zuboff[6] risuona implicitamente nell’analisi di Mhalla. La logica del “capitalismo della sorveglianza”, per Zuboff, trasforma la vita quotidiana in una fonte continua di dati comportamentali, da modellare e predire. Mhalla ne estende la portata, mostrando come l’estrazione cognitiva non serva solo al profitto aziendale, ma venga incorporata in strategie statali di influenza e controllo, dando forma a un nuovo complesso tecnosovrano.
L’Europa e la sfida della sovranità democratica
Nel delineare le geografie del Big State, Mhalla dedica ampio spazio a Stati Uniti e Cina, due modelli speculari, accomunati da un rapporto strategico tra Stato e Big Tech. In entrambi i casi, le piattaforme tecnologiche diventano protesi di potenza: strumenti di soft e hard power, dispositivi di sorveglianza e di proiezione geopolitica.
L’Europa, al contrario, appare ancora priva di una piena capacità d’azione in questo campo. L’assenza di campioni tecnologici sovrani e la dipendenza da infrastrutture digitali statunitensi e asiatiche la relegano a un ruolo secondario. Tuttavia, l’autrice non esclude la possibilità di una “terza via”: un modello europeo fondato sul pluralismo, sulla trasparenza algoritmica e sulla sovranità democratica. In quest’ottica, strumenti come il Digital Services Act, entrato in vigore nel 2023[7], rappresentano un primo tentativo di delineare uno spazio pubblico digitale europeo, capace di tutelare i diritti fondamentali e contrastare la logica estrattiva delle piattaforme. Nel capitolo conclusivo, Mhalla avanza alcune proposte normative e teoriche, volte a riaffermare una “democrazia cognitiva”. Tra queste, il riconoscimento di nuovi diritti digitali, come il diritto all’attenzione, alla comprensione trasparente degli algoritmi, al controllo sui propri dati, e la necessità di considerare le infrastrutture digitali come beni comuni, da sottrarre alla mera logica commerciale.
Tecnopolitica di Asma Mhalla non è un libro per chi cerca risposte rapide o semplici. I concetti che attraversano il testo sono densi, intrecciati e profondi, richiedendo al lettore tempo, pazienza e attenzione per districarsi nel complesso tessuto di teoria politica, tecnologia e geopolitica. Ma proprio questa complessità diventa il punto di forza del saggio, il libro ci invita a riflettere con lucidità sulle questioni più attuali e urgenti, che spesso attraversano le prime pagine dei giornali ma rischiano di rimanere superficiali.
Si pensi, per esempio, al rapporto controverso e a tratti spettacolare tra Donald Trump ed Elon Musk, simboli di una politica mediatica e tecnologica che ridefinisce il potere e la sovranità nello spazio pubblico digitale. Oppure al ruolo della Cina, non solo come attore globale ma come protagonista di una nuova geopolitica che utilizza le tecniche della psicologia e della guerra cognitiva nelle relazioni internazionali, un aspetto cruciale che Mhalla mette in luce con chiarezza.
Di fronte a tutto questo, il libro ci ricorda che la responsabilità non è solo degli Stati o dei giganti tecnologici, ma anche della società civile europea, chiamata a difendere e promuovere la trasparenza e la verità nelle informazioni. In un’epoca in cui le narrative possono contare più delle leggi, come sta accadendo nel caso emblematico del conflitto tra Israele-Hamas e del futuro della Striscia di Gaza, comprendere la centralità dell’informazione diventa un’urgenza democratica.
La sfida, dunque, non è solo normativa o tecnica, ma profondamente politica. Si tratta di immaginare una nuova forma di sovranità capace di tutelare la libertà del pensiero in un’epoca in cui l’autonomia cognitiva è divenuta un campo di battaglia. Come scrive Mhalla, la tecnopolitica non è il destino, ma lo spazio in cui si gioca una delle partite cruciali del nostro tempo, ci invita a non sottovalutare il potere delle parole, dei messaggi e delle immagini quella tra dominio e autonomia, tra manipolazione e libertà. è in questi territori che si gioca la partita più decisiva del nostro tempo, quella tra controllo e libertà, tra manipolazione e pensiero critico.
[1] Thomas Hobbes, Leviatano o la materia, forma e potere di uno stato ecclesiastico e civile (1651), trad. it. a cura di Arrigo Pacchi, con la collaborazione di Agostino Lupoli, Laterza, Roma-Bari 2001.
[2] Max Weber, La politica come professione, 1919.
[3] Michel Foucault, Sorvegliare e punire. Nascita della prigione, Einaudi, Torino 1976.
[4] Sun Tzu, L’arte della guerra, trad. it., Mondadori, Milano 2006.
[5] Daniel Kahneman, Pensieri lenti e veloci, Mondadori, Milano 2012.
[6] Shoshana Zuboff, Il capitalismo della sorveglianza, Luiss University Press, Roma 2019.
[7] Regolamento (UE) 2022/2065, Digital Services Act, in vigore dal 16 novembre 2022.